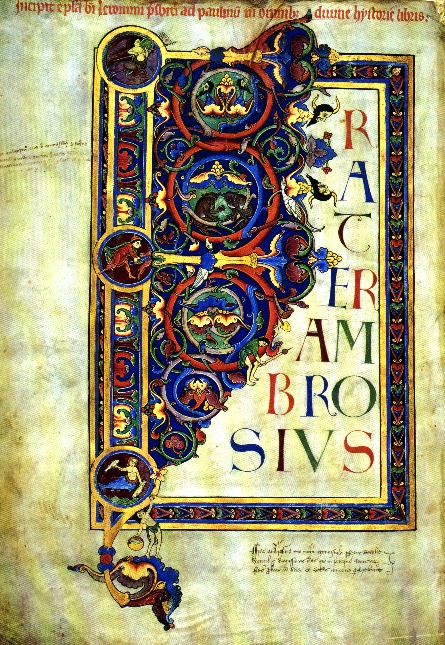
FR BERNARDO FRANCESCO M. GIANNI, OSB. OLIV.
'SI REVERA DEUM QUAERUNT'
UN TENTATIVO DI SINTESI DELLA
SPIRITUALITA' BENEDETTINA*
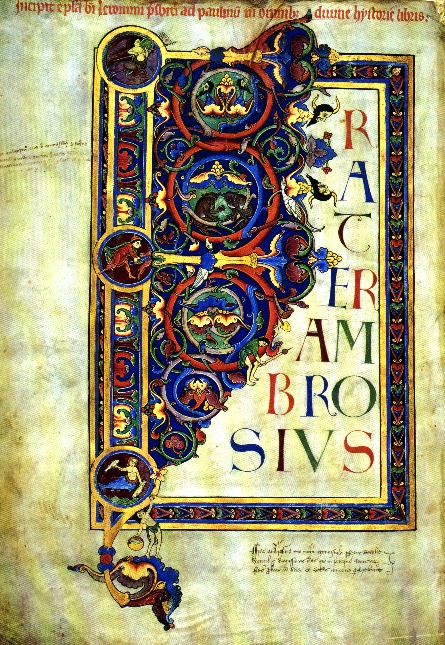
La cosa importante non è quello che di noi possono dire, ma ciò che realmente siamo. Per questo occorre essere pienamente convinti
dell’attualità del progetto monastico. Il che richiede, basandoci sulla benemerita emarginazione alla quale possiamo venire relegati e a partire dalla situazione di frontiera in cui volontariamente scegliamo di vivere, che ci confermiamo sempre più circa l’utilità della nostra «inutilità», solidamente fondata sulla morte di Gesù.fr. Clemente Serna Gonzáles OSB, abate di Silos
Monasteri d’Europa: appunti per un manifesto
 ON vuole apparire
un’oziosa stravaganza l’anteporre al tratteggio di alcuni dei
lineamenti essenziali della spiritualità benedettina un
quesito, formulato dal teologo francese Jean Daniélou, che
solo in apparenza ha i tratti dell’ovvietà:
ON vuole apparire
un’oziosa stravaganza l’anteporre al tratteggio di alcuni dei
lineamenti essenziali della spiritualità benedettina un
quesito, formulato dal teologo francese Jean Daniélou, che
solo in apparenza ha i tratti dell’ovvietà:
Quando parliamo di “spirito”, quando diciamo che “Dio è spirito”, che cosa vogliamo dire? Parliamo greco o ebraico? Se parliamo greco diciamo che Dio è immateriale. Se parliamo ebraico diciamo che Dio è un uragano, una tempesta, una potenza irresistibile. Da qui tutte le ambiguità quando si parla di spiritualità. La spiritualità consiste nel diventare immateriali o nell’essere animati dallo Spirito Santo?/1Nella prospettiva più autenticamente cristiana non vi può essere dubbio alcuno: assolutamente vera e vincente è e deve essere la seconda prospettiva giacché, come scriveva Ireneo, «gli uomini sono spirituali grazie alla partecipazione dello Spirito, ma non grazie alla privazione ed eliminazione della carne» (Adv. haer. V,6,1). Solo in forza di una siffatta visione complessiva e organica della persona umana si può dedurre una concezione più verace e meno parziale e depauperata della vita spirituale da intendersi pertanto non in maniera riduttiva soltanto come «una disciplina o un’ascesi», bensì come «un’arte di sinergia con lo Spirito Santo, l’arte di far fruttificare la sua presenza nella nostra vita» (M.I. Rupnik). E’ l’arte - potremmo sommessamente aggiungere noi - che ci insegna, passo dopo passo, a disporci alla sua opera di trasfigurazione della nostra esistenza, perseguita attraverso una dinamica e radicale sequela Christi perché Cristo stesso prenda forma in noi (Gal 4,19), viva in noi (Gal 2,20), in una sempre più totalizzante partecipazione alla vita divina (2Pt 1,4), rinnegata con forza ogni concupiscenza e ogni mondana idolatrìa. Sembra ragionevolmente conseguente la percezione che tanto l’intera nostra persona, quanto la nostra intera comunità di credenti, per le verità oggettive che sono il farsi di Cristo nostra carne e il suo primato nella storia della creazione come sua fondazione e suo definitivo compimento (Col 1,15-17 e Ef 1,9-11), sono responsabilmente chiamate nel tempo a creare spazio all’azione dello Spirito di Dio nel mondo e a darne credibile testimonianza, addirittura arrivando ad affrettare, «nella santità della condotta e nella pietà», il ritorno ultimo del Signore alla fine dei tempi, come con magnifica audacia scrive Pietro (2 Pt 3,11-12). La vita cristiana e lo sguardo e l’agire stesso del credente nel Signore Gesù paiono pertanto da inscriversi fra due luoghi biblici solo apparentemente contradditorî: da un lato la netta consapevolezza dell’assoluta novità della rigenerazione battesimale in Cristo fa scrivere a Paolo un’esortazione di radicale portata: «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra» (Col. 3, 1-2); dall’altro per rimettere in cammino gli apostoli, assorti a fissare il cielo verso dove il loro Signore ascendeva, quali «testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra» del Cristo Risorto, è necessaria la perentoria parola di «due uomini in bianche vesti» che continua ad interpellare nel nostro hodie chi osasse supporre che la fedeltà all’Evangelo non comporti l’obbligatorietà dell’annunzio e della sofferta comunione con il creato intero e le sue vicende nel tempo che ci è dato: «uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» (At 1,7-11). Fedele alla terra che il Signore gli ha affidato sin dalla creazione (Gn 1,28 e soprattutto 2,15) e non per questo meno vigilante nello scrutare il cielo, attendendo e - come si è detto - affrettando il ritorno del Signore, ogni cristiano dovrà meditare in cuor suo la bellissima sintesi di Pietro: «Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all’azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù si rivelerà» (1 Pt 1, 13)./2 Sì, è specialmente in queste coordinate bibliche che possiamo far nostra la ragionevole e pertinente prognosi di Paul Ricoeur:
possono sopravvivere solo spiritualità che rendano conto della responsabilità dell’uomo, che diano un senso all’esistenza materiale, al mondo tecnico e in modo generale alla storia. Dovranno morire le spiritualità di evasione, le spiritualità dualiste./3San Benedetto (+547), grande e geniale maestro di sintesi della tradizione monastica a lui precedente e nondimeno sensibilissimo ermeneuta della Scrittura, fin dall’esordio del Prologo della sua Regula monasteriorum suppone di rivolgersi a persone e comunità ecclesiali desiderose e capaci d’ascoltare nel loro cuore la eco incessante della voce dello Spirito Santo. Ricucendo pertanto il Salmo 95,8; Apocalisse 2,7 e Matteo 11,15, egli nello stesso Prologo della Regola così esorta: «Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore; e ancora: Chi ha orecchi per intendere, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (10-11). Mossi da un invito così autorevole e fermo non possiamo non verificare che cosa sia oggi ciò che lo Spirito Santo suggerisce alle comunità monastiche per riscoprire e custodire consapevolmente e con sereno equilibrio le radici e la linfa vitale della tradizione e, al contempo, intuire il senso, l’orientamento, il fine della nostra umile e numericamente irrilevante presenza nella grande vigna della Signore. E’ del resto indubbio come la spiritualità monastica fin dalle sue origini, da collocarsi nell’età costantiniana, al termine della grande stagione del martirio di sangue della cui radicale testimonianza il monachesimo si sentiva erede, avesse recepito nel lessico e in certi tratti della sua sensibilità l’impronta di un radicale dualismo che più che dalla Scrittura veniva assorbito da un humus culturale fortemente caratterizzato tanto dall’influsso degli ultimi epigoni delle grandi scuole filosofiche greche, quanto da certe concezioni riferibili alle eresie gnostiche e manicheiste. Tale ricezione nella letteratura monastica aveva sovente finito per divaricare termini come anima e corpo, Regno e mondo e finanche eschaton e storia, considerati così assolutamente inconciliabili fra loro da autorizzare un’interpretazione e un’autoconsapevolezza del monachesimo quale fenomeno animato da una monocorde spiritualità che individuava nella cosiddetta fuga mundi l’unica via di salvezza e il paradigma stesso della massima perfezione cristiana. Ne conseguiva che nell’organismo ecclesiale talvolta si arrivasse ad assegnare ai monaci due esclusivi ministeri: quello di una preghiera espiatoria e vicaria a favore di tutta l’umanità in forza dello specifico ed eccellente stato di perfezione di una vita segregata da ogni consorzio umano e quello di rammentare se non il dovere almeno la grande utilità riposta nella scelta radicale di fuggire dalla storia e, come è dato di leggere in non poche pagine di letteratura ascetica, di alimentare un fermo disprezzo dei beni terreni. Ma può davvero essere soltanto questa l’unica accordatura corretta per un’autentica e complessiva interpretazione anche storica del monachesimo e –più in particolare- della spiritualità benedettina? E ancora –l’interrogativo è per certi versi più importante e cogente- che cosa pare suggerire oggi lo Spirito alle Chiese e alla comunione delle comunità monastiche? A tale riguardo ci può venire utilmente incontro un mirabile passaggio della Lettera Apostolica Orientale lumen di Giovanni Paolo II, scritta nel 1995 in occasione del centenario della Orientalium dignitas di Leone XIII, che si pone come sintesi esemplare dello specifico carisma monastico, specialmente in ordine alla sua testimonianza nella chiesa e alla sua non semplificabile relazione con lo spazio e la storia dei nostri giorni, con tutto il creato e infine con l’intera famiglia umana:
Proprio nel progressivo distacco da ciò che nel mondo lo ostacola nella comunione col suo Signore, il monaco ritrova il mondo come luogo ove si riflette la bellezza del Creatore e l’amore del Redentore. Nella sua orazione il monaco pronuncia un’epiclesi dello Spirito sul mondo ed è certo che sarà esaudito, perché essa partecipa della stessa preghiera di Cristo. E così egli sente nascere in sé un amore profondo per l’umanità, quell’amore che la preghiera in Oriente così spesso celebra come attributo di Dio, l’amico degli uomini che non ha esitato a offrire suo Figlio perché il mondo fosse salvo. In questo atteggiamento è dato talora al monaco di contemplare quel mondo già trasfigurato dall’azione deificante del Cristo morto e risorto (14).E’ davvero difficile supporre che dietro queste ultime, bellissime e illuminanti parole del Pontefice non via sia anche la memoria di uno degli episodi più toccanti e rivelativi della vita di San Benedetto. Secondo la narrazione agiografica del monaco e papa Gregorio Magno (+604) infatti, a cui dobbiamo l’unica biografia di San Benedetto, il grande Patriarca cassinese ebbe soltanto verso la fine dei suoi giorni terreni, poco dopo la morte della sorella Scolastica, un’unica esperienza estatica, tale però da farci percepire alcuni tratti significativi della spiritualità propria della sua vita mistica. Narra Papa Gregorio che
mentre ancora i fratelli dormivano, l’uomo di Dio Benedetto anticipò l’ora della preghiera notturna alzandosi per le vigilie. Stava in piedi alla finestra pregando il Signore onnipotente (omnipotentem Dominum deprecans), quando improvvisamente vide, nel cuore della notte, una luce diffusa dall’alto che fugava tutte le tenebre della notte. Era luce splendente di tale chiarore che, pur irradiandosi dalle tra le tenebre, superava la stessa luce del giorno. Una cosa mirabile fece seguito in questa visione, come poi egli raccontò: il mondo intero, come fosse raccolto sotto un unico raggio di sole, fu portato sotto i suoi occhi.Il racconto precisa inoltre come nella stessa visione Benedetto avesse pure contemplato l’anima di Germano, Vescovo di Capua, che là moriva proprio in quell’istante, mentre veniva «trasportata dagli angeli in cielo, raccolta in un globo di fuoco». Gregorio ha poi cura di esplicitare al suo interlocutore, il diacono Pietro, il profondo significato spirituale di quell’evento mirabile:
Pietro, tieni bene in mente questo che ti dico: per l’anima che vede il creatore la creazione intera è piccola. Benché abbia visto solo un poco della luce del creatore, per essa diventa angusta tutta la realtà creata, in quanto, per la stessa luce della visione, si dilata la capacità più profonda dello spirito e tanto si espande in Dio da diventare superiore al mondo (breve ei fit omne quod creatum est, quia ipsa luce visionis intimae mentis laxatur sinus, tantumque expanditur in Deo, ut superior existat mundo). Anzi, l’anima di colui che vede diventa superiore perfino a se stessa (fit vero ipsa videntis anima etiam super semetipsam). Quando è rapita nella luce di Dio al di sopra di sé, si dilata nella capacità interiore e, mentre guarda sotto di sé, dall’alto comprende come sia ristretto ciò che, quand’era in basso, non poteva comprendere. Dunque l’uomo che vedeva il globo di fuoco, vedeva anche gli angeli che tornavano al cielo; e sicuramente poteva vedere tali cose solo nella luce di Dio. Perché meravigliarsi, allora, se vide raccolto dinanzi a sé il mondo, dato che era stato sollevato al di sopra di esso nella luce dello spirito? Quando si parla di mondo raccolto davanti ai suoi occhi, non s’intende che il cielo e la terra si siano contratti, ma che lo spirito del contemplativo s’è dilatato: rapito in Dio, poté vedere senza ostacolo tutto ciò che è al di sotto di Dio. A quella luce che rifulse agli occhi del corpo corrispondeva una luce interiore dello spirito che rapì l’animo del contemplativo alle realtà dell’alto e gli mostrò quanto fossero anguste tutte le realtà di quaggiù (Liber Dialogorum II,35,2-7).Se Benedetto aveva inaugurato il suo magnifico itinerario spirituale e monastico con il risoluto abbandono della casa paterna, degli agi famigliari e degli studi “liberali” a Roma nella chiara e severa consapevolezza di dover «disprezzare il mondo, nella sua piena fioritura, come fosse già inaridito (despexit iam quasi aridum mundum cum flore)» (Gregorio Magno, Liber Dialogorum II, prol.), al termine della sua vita la despectio si è però trasformata in una inspectio: una visione profonda, accogliente e comprensiva («intimae mentis laxatur sinus») che vede il «piccolo» creato nella prospettiva totalizzante del Dio creatore, cioè dell’amore sovrabbondante sulla cui immensità si dimensiona lo sguardo dilatato dell’uomo di Dio. In altre parole è «in Dio», e cioè entro il vissuto di fede nel mistero di Dio, che è visto il creato ed è solo così che è colta la sua verità, e non in una semplicistica contrapposizione o divaricante esclusione. Pur con tutti i suoi angusti confini e tutta la sua provvisorietà nella «dilatazione» dello sguardo, scomparsa ogni meschinità angusta, il mondo è «visto» entro un raggio di sole, quasi percepito come unificato dalla presenza diffusiva e luminosa di Dio e del suo amore. E d’altro canto Dio stesso è colto ed espresso mediante l’immagine di un’esperienza cosmica: un raggio splendente di sole. Non voleva forse il Santo Padre evocare qualcosa di molto simile a questa estasi di luce al contempo divina e creaturale quando ci suggeriva come «nella comunione col suo Signore, il monaco ritrova il mondo come luogo ove si riflette la bellezza del Creatore e l’amore del Redentore» e quando prospettava per il monaco la possibilità di «contemplare quel mondo già trasfigurato dall’azione deificante del Cristo morto e risorto», purché nasca nel cuore «un amore profondo per l’umanità, quell’amore che la preghiera in Oriente così spesso celebra come attributo di Dio»?
E’ la conquista di questo orizzonte di amore cosmico in Cristo per Dio e la sua creazione, superata così ogni rigida e antitetica contrapposizione, la meta ultima del cammino del monaco che Benedetto aveva tuttavia significativamente iniziato nella severa solitudine di una grotta, per imparare a consumare il suo cuore per Dio e a disporsi alla sua misericordia, piuttosto che farsi grande con le proprie forze, le sicurezze ereditate e gli onori mondani della polis, nella liberante dedizione al servizio per l’unico Signore./4 Del resto, nella memoria biblica della chiesa, non è forse il deserto il luogo dell’apprendistato d’Israele per affrontare responsabilmente le nuove vie esodiche della libertà pasquale e per imparare attraverso l’umiliazione e la fame la sua dipendenza assoluta dall’amore e dalla Parola di Dio (Dt, 8,2-3)? E non è il deserto il luogo dove il Signore Gesù, prima di inaugurare la missione, è condotto dallo Spirito per essere messo alla prova e vincere ogni tentazione con la forza donata dal compiacimento del Padre? Uscendo da quel deserto, dove ha guadato il fiume carsico della sua umanità prendendo su di sé il peccato del mondo per toglierlo (Gv 1,29), Gesù esce vittorioso per trasfigurare gli uomini donando la sua guarigione e la sua parola di vita.
Dopo il fallimento di una prima esperienza di paternità monastica, respinta con un tentativo di avvelenamento procurato da monaci riottosi a qualsiasi conversio morum, Benedetto sente il bisogno di tornare senza indugio all’humus fertile dello scabro deserto per riappropriarsi in pienezza della capacità di habitare secum che altro non è, ci spiega Gregorio Magno, se non la perseverante dimora nella percezione della costante presenza di Dio e la conseguente custodia di una signoria amorosa e vigilante sulla propria interiorità riconosciuta come il luogo sorgivo della somiglianza originaria col Creatore, il cui liberante recupero è senz’altro equiparabile all’evangelico redire in se del figliol prodigo pentito (Lc 15,11-17: cfr. Liber Dialogorum II,3,5-9). Analogamente è la ferma decisione di fare sempre memoria nella propria esistenza di questa incessante presenza di Dio come unico e vero signore della nostra vita e di ascoltarne la parola che a Lui riconduce, la prima tappa del cammino di conoscenza di sé nell’umiltà proposto personalmente da Benedetto al discepolo nella sua Regola fin dal primo versetto del Prologo e fin dal primo gradino della scala dell’umiltà in un duplice itinerario che ha per meta il ritorno al proprio cuore e l’ingresso nella gloria del Regno (RB 7,10-30). Nello stesso deserto egli fa un’ulteriore e decisiva esperienza la cui memoria ritroveremo in non pochi passaggi della Regola: la vita al servizio di Dio e la ricerca del suo volto non sono una palestra di lotta ascetica per la conquista di una qualche appagante virtù di perfezione, ma un lungo cammino di scoperta della nostra totale dipendenza dall’amore misericordioso di Dio che visita e rianima il nostro cuore bruciato dalla tentazione del dominio, dell’orgoglio e dell’autosufficienza. Gregorio non manca infatti di raccontarci come sia nella solitudine il luogo in cui Benedetto subisce l’umiliante esperienza della propria debolezza quando, tentato nella carne, «meditò già di abbandonare il deserto, vinto dal desiderio; ma ad un tratto la grazia divina lo guardò e rientrò in se stesso (cum subito superna gratia respectus, ad semetipsos reversus est)» (Liber Dialogorum II,2,1-3). Grazie al perseverante sforzo di habitare secum al cospetto di Dio Benedetto riesce tuttavia, non senza l’imprescindibile aiuto della grazia, a tornare nel luogo dove vive l’uomo nascosto del cuore (1Pt 3, 4): l’esperienza viva di questa mezza vittoria impastata di umiliazione e misericordia renderà subito dopo Benedetto capace di altrettanta paternità nell’umiltà, nella misericordia e nel cammino di liberazione dalla brama di possesso e di dominio sull’altro: «Cominciò da quell’ora l’afflusso di molti, che lasciando il mondo, accorrevano alla sua scuola. E giustamente: liberato dal male della tentazione, egli era ormai diventato maestro di virtù». Non meraviglia pertanto verificare come l’abate che Benedetto vorrà come padre di monaci sia un «esigente maestro», ma nondimeno «tenerissimo padre» (RB 2,24), che «nei suoi giudizi faccia sempre prevalere la misericordia, per essere a sua volta giudicato con misericordia» e che «consideri sempre la propria fragilità» (RB 64,10 e 13). E non può che avere la fisionomia spirituale del pubblicano l’immagine ideale del monaco proposta da Benedetto nel dodicesimo e ultimo gradino della scala dell’umiltà: quel monaco che «permeato di umiltà nell’intimo del cuore», nella «consapevolezza dei suoi peccati… va ripetendo senza posa nel suo cuore le parole del pubblicano del Vangelo che, con gli occhi abbassati, diceva: ‘Signore non sono degno, io peccatore di alzare gli occhi al cielo’ (Lc 18,13-14) e con il profeta dice pure: ‘mi sono curvato e umiliato fino all’estremo’ (Sal 38,7-9)» (RB 7,62-66). Santa Caterina da Siena sembra aver avuto presente questo magistero e quest’esperienza tramandata dall’agiografia benedettina di Gregorio quando, scrivendo ai monaci di Cervaia, avverte:
Voglio dunque che apriate l’occhio della ragione, fratelli miei, per conoscere voi stessi; poiché nel conoscimento di se stessi l’anima si umilia. Questo conoscimento si accresce per le molte tenebre e le molestie del demonio, e cresce in sollecitudine ed in amore di Dio, poiché vede che senza di lui non si può difendere, e trova Dio in se stesso con buona e santa volontà.Come si notava all’inizio l’autentica vita spirituale cristiana non solo ha in odio e sente aliena da sé qualsiasi scorciatoia dualistica ma vive e s’accresce dinamicamente osando assumere ed affrontare il limite oscuro del peccato forte soltanto dell’umile consapevolezza che il credente è creatura in Cristo già perdonata e resa grande solo dall’accoglienza dell’amore donato da Dio. Il cateriniano «trovare Dio in se stesso con buona e santa volontà» sarà pertanto il compimento di un cammino che in Benedetto è irrinunciabile: quello dell’obbedienza intesa come ascolto radicale ed esistenziale (ob-audire) offerto alla Parola del Signore, dell’Abate, vicario paterno di Cristo, e in ultimo a quella di tutti i fratelli.
Ascolta figlio mio, gli insegnamenti del Maestro, apri docile l’orecchio del tuo cuore, accogli volentieri i consigli del tuo padre buono e impegnati con vigore a metterli in pratica. Attraverso la fatica laboriosa dell’obbedienza, potrai così ritornare a Colui dal quale ti eri allontanato cedendo alla pigrizia della disobbedienza. A te si rivolge dunque questo mio discorso, chiunque tu sia, che rinunziando alle tue propria volontà, per servire Cristo Signore, il vero re, assumi le fortissime e gloriose armi dell’obbedienza (RB Prol. 1-3).E’ importante riportare un ulteriore passaggio del Prologo dove si evince chiaramente come il monaco debba sempre considerarsi un chiamato, un cercato, un convocato dalla misericordia di Dio, contro ogni nostra fallace supposizione di autosufficiente perfezione. Il monaco è colui che nella sua esistenza ha intuito e intuisce un luminoso percorso di salvezza attraverso l’ascolto vigilante della Parola rivolta dal Signore nel nostro hodie in forza del mistero pasquale nascosto nella storia della salvezza ancora in atto:
Leviamoci dunque, finalmente, poiché la Scrittura ci scuote dicendo: «E’ ormai tempo di svegliarci dal sonno». Gli occhi nostri spalancati alla luce divina, gli orecchi attoniti per lo stupore, ascoltiamo la voce di Dio che ogni giorno si rivolge a noi gridando: «Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore»; e ancora: «Chi ha orecchi per intendere, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.» E che dice? «Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore. Correte mentre avete la luce della vita, perché non vi sorprendano le tenebre della morte» (RB Prol. 8-13).Non meraviglino quegli «occhi spalancati alla luce divina»: leggendo il racconto agiografico di Gregorio (Liber Dialogorum, II,35-36) ci si accorge di un nesso intimo e non accidentale fra l’estasi cosmica di cui abbiamo già parlato e la scrittura stessa della Regola. La visione escatologica del mondo raccolto in un raggio di luce divina come anticipo della consumazione finale della storia e del cosmo suggerisce e ispira a Benedetto una Regola plasmata dalla Parola di Dio che con l’ulteriore riferimento a quella stessa Parola contenuta nelle divine Scritture/5 possa essere per i suoi monaci norma di un cammino umile verso lo stesso esito di gloria e di grazia:
Ecco, il Signore, nella sua grande bontà, ci mostra il cammino della vita. Cinti dunque i fianchi con una fede robusta e comprovata dal compimento delle buone opere, procediamo sulle vie del Signore, sotto la guida del Vangelo, per meritare di vedere Colui che ci ha chiamati al suo regno… Sì, a quella dimora giungeranno coloro che, pervasi dal timore di Dio, non si inorgogliscono per la loro esatta osservanza, ma consapevoli che quanto c’è in loro di buono supera le loro capacità ed è unicamente frutto della grazia divina, magnificano il Signore che opera in loro… Prepariamo, dunque, i nostri corpi e i nostri cuori a prestare servizio sotto la santa obbedienza ai divini comandamenti. E se la nostra natura davanti a qualcosa si sente impotente, supplichiamo il Signore che ce ne renda capaci dandoci l’aiuto della sua grazia (RB Prol. 20.29-30.40-41).L’ulteriore insistenza di Benedetto per l’obbedienza andrà giustificata in forza della sua visione antropologica che ha trovato in Bernardo di Chiaravalle un magnifico ermeneuta come si può verificare da questo testo che con una certa pertinenza possiamo accostare al testo cateriniano:
Per la volontà buona noi diventiamo proprietà di Dio. Dio creò la volontà dell’uomo buona, libera, come primizia della sua creazione. Sarebbe stato meglio per noi non esistere del tutto che essere totalmente indipendenti. Poiché quelli che aspirano ad essere indipendenti, come degli dei, conoscitori del bene e del male, invece di diventare padroni di se stessi, si convertono in schiavi del diavolo. Perciò, la volontà libera ci fa padroni di noi stessi, la cattiva volontà ci rende schiavi del diavolo; la buona volontà ci fa proprietà di Dio (De gratia et libero arbitrio VI,18,23-29).Bernardo, certamente memore di Genesi 3 e di Romani 6,17, ci fa capire con questa celebre distinzione la centralità dell’obbedienza in quella «scuola di servizio del Signore», (significativamente così Benedetto chiama il monastero: RB, Prol. 45): l’obbedienza è vissuta dal monaco come memoria continua del suo cammino di conversione intrapreso e come sigillo radicale di una prassi rinnovata dalla decisione assunta di volersi riconsegnare a Dio nella riscoperta della nostra totale appartenenza a Lui e nell’orizzonte di una progressiva e definitiva riunificazione mistica ed escatologica. Ed è pure qui che possiamo cogliere l’assoluta peculiarità del monachesimo benedettino e più in generale di quello cristiano, e cioè, appunto, lo strettissimo riferimento cristologico che sostanzia di sé tutta la Regola e la sua spiritualità benedettina. Tutto sommato agli inizî della stessa Regola Benedetto colloca uno specifico capitolo sull’obbedienza che ha questo chiarissimo incipit: «Il primo gradino dell’umiltà è l’obbedienza immediata. Essa è propria di coloro che ritengono di non avere assolutamente nulla di più caro di Cristo» (RB 5,1-2 e cfr. anche RB 4,21). La stessa lapidaria affermazione torna nel penultimo capitolo, quasi al modo di una significativa inclusione: «Nulla assolutamente anteporre a Cristo» (RB 72,11). L’insistenza è parenetica e teologica al contempo: tutta la vita del monaco deve essere radicata in Cristo ed esistenzialmente modellata da un rapporto vitale con lui. Si rivela qui, nel primato dell’amore a Cristo, il carattere radicalmente battesimale della spiritualità monastica più genuina che è peculiare di persone, uomini e donne, chiamati a testimoniare e a celebrare, nella prassi feriale e silenziosa della loro vita di comunione fraterna, di accoglienza, di preghiera, di ascolto e di lavoro, l’umiltà salvifica della kenosis del Verbo, l’esemplarità del suo servizio di amore suggellata dal comandamento nuovo e nondimeno, con tutto questo, la signoria di Gesù Cristo sulla morte e sul peccato e la conseguente liberazione dell’uomo donata per sempre dalla Pasqua di Risurrezione. Possiamo così meglio comprendere la portata assolutamente teologica del tema, centrale nella Regola, dell’obbedienza, talvolta purtroppo depauperato perché collocato solo entro un orizzonte puramente umano o peggio ancora gerarchico e giuridico e che invece Benedetto innesta precisamente nel cuore della relazione fra il Padre e il Figlio: «uomini simili si conformano certamente alla parola del Signore che dice: “Non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” (Gv 6,38)» (RB 5,13). E’ proprio questa forte connotazione cristologica a convincere Benedetto che sia la prassi dell’obbedienza a divenire la via regia dell’assimilazione mistica del monaco a Dio./6 Se infatti nel Prologo questa era vista ancora come «labor» (RB, Prol. 2), nelle ultime pagine della Regola essa diviene «bonum» e addirittura, in un’amplificazione solo a prima vista sconcertante, la norma costante di una costante reciprocità comunionale in vigore fra tutti i fratelli, fatta salva la primazia dell’abate: «l’obbedienza è un bene così grande che i fratelli devono sentire il bisogno non solo di offrirla all’abate, ma anche di scambiarsela tra di loro, convinti unicamente per questa via dell’obbedienza andranno a Dio» (RB 71,1-2). D’altro canto l’abate non è affatto chiamato a far da padrone sulla fede del suo gregge (cfr. 2 Cor 1,24) ma a farsi modello di servizio e carità obbedendo lui stesso alla Parola del Signore: «L’abate nulla deve insegnare, stabilire o comandare che si discosti dalla legge del Signore» (RB 2,4). E’ dunque in una sapiente circolarità fra Parola di Dio, abate e comunità che andrà vista la sorgente teologica della pax e della concordia di molteplici volontà riunite e assimilate a Cristo che rendono «fortissimum» il «genus» dei monaci cenobiti (RB 1,13). Benedetto senza dubbio raccoglie in questo suo magistero l’eredità dei Padri nella visione spirituale di un’obbedienza che conduce l’uomo a Dio, lo inserisce nel dinamismo trinitario e lo rende partecipe della sua incorruttibilità, come dimostra un magnifico passo di Ireneo che ben motiva il senso della centralità della via dell’obbedienza in ordine alla divinizzazione dell’uomo in Cristo: «Tutte le altre cose (ciò che è creato) sono inferiori a Dio e a lui soggette… con tale ordine, ritmo e condotta l’uomo originato e plasmato da Dio è fatto a immagine e somiglianza del Dio increato: il Padre determina e ordina, il Figlio eseguisce e plasma, lo Spirito nutre e sviluppa e l’uomo quotidianamente progredisce e giunge alla perfezione, cioè si avvicina all’Increato… L’uomo è destinato a vedere Dio e la visione di Dio produce l’incorruttibilità…» (Adv. haer. IV,38,3). E’ dunque primariamente nell’obbedienza che troviamo la quotidiana modalità con cui il monaco attua nella sua vita la simpatia radicale che lo lega al Cristo Signore e Salvatore in una predilezione assoluta. L’indole dinamica ed escatologica di tale simpatia è chiara fin dal magnifico e rivelativo explicit dello stesso Prologo della Regola (49-50):
ma poi, avanzando nel cammino di conversione e di fede, si corre con corre con cuore dilatato e con ineffabile dolcezza di amore sulla via dei divini comandamenti. E così non scostandoci mai dal magistero di Dio, anzi perseverando nel suo insegnamento, stabili in monastero fino alla morte, parteciperemo, con il nostro mite patire, alle sofferenze del Cristo, per meritare di condividerne pure la gloria nel suo Regno./7Umiltà e obbedienza sono pertanto gli elementi che sostanziano l’imitazione che assimilerà il monaco a Cristo, Maestro umile e Salvatore obbediente, in una simpatia a lui promessa per tutta la vita al fine di apprendere, nella schola caritatis del monastero, quell’amore perfetto che ci rende consapevoli di essere creature pasquali perché liberate in Cristo dallo Spirito Santo in vista del ritorno alla piena figliolanza divina persa col peccato. La conclusione trinitaria del trattato benedettino sull’umiltà è a proposito di meridiana evidenza:
Ascesi dunque tutti questi gradi di umiltà, il monaco perverrà a quell’amore di Dio che essendo perfetto, scaccia il timore. Grazie a questo amore, ciò che prima faceva solo sotto lo stimolo della paura, comincerà a compierlo senza alcun sforzo, quasi spontaneamente, spinto dalla buona consuetudine. Allora non agirà più per timore dell’inferno, ma per amore del Cristo e per l’abitudine al bene e la dolcezza che deriva dalla pratica delle virtù. Ecco quanto il Signore si degnerà di mostrare –con l’azione dello Spirito Santo- nel suo servo ormai purificato dai suoi vizi e dai suoi peccati (RB 7,67-70).Come si vede le linee geometriche e severe della spiritualità benedettina, ben espresse nell’immaginario comune dalla rigorosa architettura claustrale e dall’incalzante scansione della liturgia, custodiscono nel segreto un progetto di amore che include nel suo lessico anche mirabili e tenerissime parole come quelle appena lette: delectatio virtutum (RB 7,69) e più ancora dilatato corde, inenarrabili dilectionis dulcedine (RB, Prol. 49), quest’ultime forse eco della «gioia indicibile e gloriosa» con cui Pietro qualifica l’«esultanza» dei suoi interlocutori che credono e amano il Signore Gesù «pur senza averlo visto» (1Pt, 1,8). E’ davvero la dilectio l’esperienza mistica, per l’appunto ineffabile, che il monaco fa del Signore Gesù lungo il cammino feriale ed oggettivo dell’umiltà e dell’obbedienza in una paziente e mai esausta ansia di piena comunione coi fratelli. Un pur austero maestro della riforma monastica benedettina nell’età gregoriana, San Giovanni Gualberto (+1073), fondatore di Vallombrosa, in una sua magistrale lettera sulla carità, ci aiuta a comprendere, riportandoci al cuore del mistero stesso dell’Incarnazione, come sia l’amore di Cristo e per Cristo a consentirci una viva esperienza di lui e ad esigere però al contempo un forte vincolo di carità fraterna in forza dell’obbedienza alla sua parola e in vista di una reale edificazione del corpo di Cristo che è la chiesa, secondo la concreta prospettiva di Efesini 1,22-23; 4,1-32 e pure di Colossesi 3,15:
La carità è, senza dubbio, quella virtù che ha spinto il Creatore di tutte le cose a farsi creatura. E’ la virtù che egli ha raccomandato agli apostoli come sintesi di tutti i suoi comandamenti, dicendo: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 15,12)… Chi è superbo e disubbidiente, sentendo questa mia affermazione, pensa di possedere la carità per il fatto che rimane corporalmente in mezzo ai fratelli. Ma ecco che il beato Gregorio lo disinganna da questa falsa opinione e indica giustamente il fine della carità dicendo: Ama perfettamente Dio chi non lascia per sé nulla di sé… Se le cose stanno così, anzi proprio perché stanno realmente così, ogni fedele deve sempre considerare come potersi unire a un bene così grande e cercare con impegno di trarre con sé verso di esso anche i suoi compagni nella via del Signore. Come i reprobi, abbandonando la carità, si separano dal corpo di Cristo, così gli eletti, abbracciandola con sincerità si uniscono stabilmente allo stesso corpo di Cristo. Per custodire poi inviolabilmente questa virtù, è immensamente utile la comunione dei fratelli raccolti insieme sotto il governo di una sola persona. Come infatti il fiume si prosciuga nel suo letto se si divide in tanti rigagnoli, così l’unione fraterna è meno utile ai singoli, se si disperde qua e là.Comprendiamo bene così il grande depauperamento subìto dalla spiritualità monastica allorquando è stata vissuta come un individualistico cammino di perfezione, intrecciato con quello di altre persone per finalità eminentemente penitenziali: è piuttosto, come si è visto, l’estremo realismo della cristologia e dell’ecclesiologia paoline sottese alla Regola benedettina ad impedire qualsiasi deformazione in tale senso. Le raccomandazioni del fondatore di Vallombrosa lasciano intravedere in filigrana le stupende esortazioni con cui Benedetto avvia a conclusione la sua Regola, in un sintetico, penultimo capitolo dove la pienezza della comunione dei fratelli e la loro predilezione a Cristo, sorgente ed esito di quella, rimpiazza nettamente l’indicazione di un qualsiasi primato da assegnarsi ad una contemplazione solipsistica del mistero e tanto meno ad una pratica ascetica fine a se stessa. Anzi il tessuto necessariamente composito della comunità, nella inevitabile disuguaglianza di trama e ordito di virtù e infermità, se annodato nella reciproca carità in Cristo e in quella per Cristo pare rivelare come disegno ultimo l’esito pasquale del ritorno al Paradiso di tutti i fratelli:
questo è lo zelo che i monaci devono coltivare con il più ardente amore: si prevengano nello stimarsi a vicenda; sopportino con instancabile pazienza le loro infermità fisiche e morali; facciano a gara nell’obbedirsi a vicenda; nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma quello degli altri; amino con cuore casto tutti i fratelli; temano Dio con trasporto d’amore; vogliano bene al loro abate dimostrandogli una carità umile e sincera; nulla assolutamente antepongano al Cristo ed egli ci conduca tutti insieme alla vita eterna (RB 72, 3-12).D’altro canto, a monte di questo esito escatologico, la chiara coscienza della libertà in Cristo, unico Signore di ogni persona, imponeva a Benedetto ogni sforzo normativo per superare senza mediazioni le ben gerarchizzate strutture sociali del suo tempo a favore dell’unica appartenenza al corpo di Cristo di ogni fratello di una comunità che, anche con la rigorosa condivisione dei beni (RB 33), vuol farsi autentica e credibile testimone del Regno sopraggiunto nella storia:
ciascuno tenga il proprio posto, perché schiavi o liberi, tutti siamo uno in Cristo e servendo l’unico Signore, portiamo tutti il giogo della stessa disciplina. Infatti presso Dio non c’è parzialità; l’unico titolo di merito ai suoi occhi è questo: essere migliori degli altri nel compiere il bene e vivere nell’umiltà (RB 2, 20-21).Ma è ancora la primazia dell’amore simpatetico del monaco per Cristo ad allargare di necessità lo sguardo amoroso del monaco oltre i confini stessi della comunità monastica. Per Benedetto, memore di Matteo 25,34-46, oltre che nella membra vive del corpo comunitario ed ecclesiale il Cristo è infatti realmente presente anche in quelle, sovente sofferenti e sempre bisognose, dell’ospite, specie se povero, sia esso il pellegrino nella comune fede, sia esso l’assolutamente ignoto e sconosciuto, straniero e diverso:
Tutti gli ospiti che giungono al monastero, siano accolti come Cristo, poiché un giorno egli ci dirà: Ero forestiero e mi avete ospitato. A tutti si renda il dovuto onore, particolarmente ai fratelli nella fede e ai pellegrini… Agli ospiti che arrivano o che partono sia dato il saluto con profonda umiltà: il capo chino, il capo prostrato fino a terra, si adori in essi il Cristo che viene realmente accolto. Soprattutto verso i poveri e i pellegrini ci si prodighi in premurosa accoglienza , perché proprio in essi maggiormente si riceve il Cristo (RB 53,1-2.6-7.15).Con l’esplicito precetto della lavanda dei piedi Benedetto vuole che all’arrivo dell’ospite si crei una singolare esperienza della presenza del Signore Gesù: l’abate, che in monastero «tiene le veci di Cristo» (RB 2,2), si rende umile e ubbidiente alla sua Parola lavando coi suoi monaci le mani e pure i piedi del Cristo povero e forestiero (RB 53,12-13). Il successivo invito a ripetere col Salmista il versetto «abbiamo ricevuto, o Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio» (Sal 48,10) ci dà il tono giusto per interpretare il profondo significato teologico e umano dell’accoglienza monastica: essa allena il monaco a riconoscere la presenza del Signore viandante nel tempo e negli spazî della storia, nascosto nel volto dell’altro che non solo è da servire e ristorare ma anche da onorare (RB 4,8: «honorare omnes homines») e da amare come segno pasquale della sollecitudine del Cristo che viene a visitare e a lasciarsi amare dai suoi discepoli. Come poteva dimenticare Benedetto che il Signore, quando il rigore della sua solitudine gli aveva fatto perdere di vista lo scorrere del tempo liturgico, aveva suggerito ad un prete di recarsi dall’uomo di Dio con del cibo per ricordargli che era sopraggiunta la Pasqua e che questa andava celebrata con un pasto fraterno? Nella risposta di Benedetto al prete troviamo così abbreviata tutta la teologia monastica dell’ospitalità: «E’ davvero Pasqua, perché ho avuto la grazia di vederti!» (Gregorio Magno, Liber Dialogorum II,1,7). La radicale simpatia del monaco per Cristo non può non invitarlo ad apprendere dal suo Signore altrettanta simpatia misericordiosa per tutta l’umanità e il mondo intero, contro ogni prospettiva che, come si diceva all’inizio, fosse tentata da troppo rapide scorciatoie oltre gli spazî e i tempi sofferti della storia. Come avverte Bernardo di Clairvaux «il misericordioso coglie la verità del suo prossimo, conformandosi a lui con simpatia, così da vivere le sue gioie e i suoi dolori come se fossero i proprî: debole con i deboli, pronto a gioire con coloro che sono felici e a piangere con coloro che piangono». Sia con l’umile e nascosto dono orante di una memoria sofferta e attenta, sia con quello di un ascolto paziente e fecondo, sia con quello di una parola di consolazione o di un fraterno abbraccio di viva e reciproca amicizia, o sia con una radicale testimonianza di sangue come quella lasciata dai sette monaci trappisti sgozzati da alcuni fondamentalisti islamici in Algeria nel 1996 solo perché responsabili di aver voluto testimoniare con la loro vita fraterna di preghiera, lavoro e accoglienza «che la pace tra i popoli è un dono di Dio fatto agli uomini di ogni luogo e di ogni tempo e che spetta ai credenti, qui e ora, rendere manifesto questo dono inalienabile»,/8 ogni monaco autenticamente fedele all’Evangelo del suo Signore e commosso dalle sue lacrime di commozione versate su Gerusalemme (Lc 19,41-42) non può non adempiere alla mirabile esortazione di un altro grande cisterciense, Aelredo di Rievaulx, così da trasformare il proprio cuore in un immenso spazio di accoglienza:
riunisci il mondo intero nel profondo del tuo amore e lì, tutto insieme, contempla i tuoi fratelli uomini, gioisci per alcuni e piangi per gli altri. Lì, fissa il tuo sguardo su coloro che soffrono, su coloro che sono oppressi e soffri insieme a loro; lì si incontrino la miseria dei poveri, i singhiozzi degli orfani, la desolazione delle vedove, il dolore di chi è affranto, i bisogni di coloro che sono in viaggio… le preoccupazioni dei preti, le sofferenze di coloro che sono in guerra. A tutti apri un cuore pieno di amore, versa per loro le tue lacrime e offri le tue preghiere.Con una sempre più radicale e sofferta simpatia per Cristo (cfr. Col 1,24), il monaco giungerà a questi esiti di piena assimilazione a lui, nella fedele perseveranza di un cammino di ricerca promesso per tutta una vita e intrapreso in vista di un volto dal quale egli si sente a sua volta cercato. E’ un dinamismo interiore di amore amante e amato che in quella «scuola del servizio divino» che è il cenobio trova il suo percorso concreto e oggettivo nella quotidiana fedeltà al ritmo della liturgia, al bene faticoso dell’obbedienza e all’umiltà come pedagogia incessante del nostro cuore. Mai si allenta nella spiritualità più autenticamente cristiana il nesso amoroso e dinamico che lega la creatura al suo creatore e le creature fra di loro: la spiritualità benedettina non sfugge a questa aurea norma irrinunciabile per chi vuole obbedire e conformarsi a colui che ci insegna «a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo» (Tt 2,12). Si può così finalmente rendere ragione del titolo collocato in testa a queste pagine che rimanda al requisito di cui Benedetto esige con fermezza la verifica per ammettere un candidato alla vita monastica:
Si osservi soprattutto se egli cerca veramente Dio (si revera Deum quaerit), se si dedica con amore all’Opera di Dio, all’obbedienza e se sa accettare le umiliazioni. Gli si prospetti chiaramente attraverso quali durezze e fatiche passa la via che conduce a Dio (RB 58,7-8).L’Opus Dei, che nella tradizione basiliana significava tutta l’intera vita ascetica, in Benedetto assume il significato della preghiera liturgica celebrata nell’ufficiatura corale. Essa assume una centralità e una sovreminenza nel ritmo del tempo monastico che Benedetto ha cura di sottolineare esplicitamente: «Quando è l’ora dell’Ufficio divino, appena udito il segno, si lasci tutto quanto si ha tra mano e si accorra con grande premura, ma insieme con gravità, per non offrire pretesto alla dissipazione. Nulla, dunque, si anteponga all’Opera di Dio» (RB 43,1-3). Non può sfuggire come quest’ultimo asserto ci riporti alla assoluta predilezione che il monaco nutre per il Signore Gesù: «Nulla assolutamente anteporre a Cristo» (RB 72,11). Simpatia di predilezione nella fede cristologica come ci conferma l’illuminante dialogo giovanneo, cui purtroppo mai abbastanza si fa riferimento nel trattare questo aspetto decisivo della vita quotidiana del monaco: «‘Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?’. Gesù rispose: ‘Questa è l’opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato’» (Gv 6,28-29). Fede e amore nel Signore Gesù convocano dunque il monaco a magnificarne coi fratelli la sua piena signorìa sul tempo, a celebrarne la sua passione e la sua vittoria pasquale nell’Eucarestia come mistero di salvezza ancora all’opera nella storia del nostro hodie, ad ascoltarne la Parola di vita, ad obbedire già nella simbologia del rito al suo comandamento nuovo come membra congiunte di un unico corpo, a profetizzare la piena comunione che sarà del banchetto escatologico e dei cori celesti, a testimoniare infine che ogni opera compiuta dall’uomo per il Signore è in definitiva l’umile e liberante scoperta che è Dio stesso all’opera in noi che gli doniamo il cuore e il canto in sintonia perfetta fra loro./9 Unito a Gesù che vegliava sul mondo dinanzi al Padre mentre i discepoli «dormivano per la tristezza» (Lc 22,45), il monaco, anche nelle ore tenebrose e angoscianti della notte, osa annunziare e testimoniare, nella koinonìa dei fratelli salmodianti, «la beata speranza» invocando e attendendo «la manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo» (Tt 2,13). Nella concretezza oggettiva del ritmo liturgico il monaco è invitato di frequente ad “alfabetizzare” il suo amore per il Cristo: il lungo silenzio della notte si interrompe in monastero al canto delle vigilie quando l’orante inizia il dialogo con Dio rivolgendogli per tre volte con la parola del Salmista (Sal 51,17) la richiesta di aprirgli la bocca per rompere l’infanzia notturna, magnifico simbolo della nostra fragilità e inadeguatezza di fronte al mistero del suo amore che ci convoca (RB 9,1). E tutta la durata di una giornata, in accordo con la simbologia cosmica e i tempi della vicenda storica di Gesù e dei suoi discepoli, permette così di sperimentare l’amore fedele sotteso all’alleanza sponsale stipulata nel tempo fra il Signore Gesù e la sua chiesa. La liturgia, sorgente ed esito di una incessante preghiera personale,/10 si determina come momento privilegiato in cui, resa salda con l’ascolto degli eventi biblici la memoria mirabilium Dei, il monaco si fa meno vacillante trasformandosi in colui che con speranza teologale si lascia giudicare e guidare dalla Parola di Dio nella concretezza del tempo storico presente in cui percepisce l’azione permanente della volontà salvifica del Padre./11 Nella sua predilezione a Cristo egli non dovrebbe faticare a ravvisare in lui il centro e il fine di questa historia salutis come molte absidi dai bagliori dorati di preziosi mosaici raffiguranti il Cristo Pantokrator vogliono suggerirci.
Nella pur affascinante e apparente monotonia delle giornate monastiche, che Roland Barthes con finezza letteraria chiamava una «quotidianità senza avvenimenti», la liturgia, lungi dall’essere soltanto esercizio mnemonico, ben al contrario inserisce nel tempo feriale, settimanale e annuale che ora ci è dato, gli immensi avvenimenti della nostra salvezza in Cristo aprendoli alla prospettiva futura pure in loro inscritta: è allora qui che la comunità ecclesiale, nuovo Israele liberato da Cristo, in comunione con l’intera famiglia umana e assieme a tutto il cosmo soffre le doglie della gestazione e del parto della nuova creazione (Rm 8,22-25). Ed ecco perché nella visione più autenticamente benedettina, contro ogni esasperazione cultualistica e peggio ancora giuridicista, la liturgia è sì, come amano ancora ripetere i nostri fratelli ortodossi, “il cielo sulla terra”, ma essa è anche ontologicamente legata alla storia e alla vita quotidiana nell’unica economia salvifica che vede sommamente intrecciate l’opus Dei e l’opus hominis. Lo dimostra la teologia benedettina del lavoro che si desume con chiarezza già dal capitolo dedicato ai monaci che lavorano lontano dall’oratorio: «I fratelli che lavorano molto lontano e non possono accorrere all’oratorio all’ora dovuta… celebrino l’Opera di Dio nel luogo stesso in cui si trovano a lavorare piegando le ginocchia con somma riverenza a Dio» (RB 50,1-3). La predilezione esistenziale del monaco per il Signore Gesù non può non trasformarsi in imitazione della sua povertà e in confessione non teorica ma concreta della sua divinità e della sua umanità: il monaco che lavora risponde ad un appello non meno teologico e urgente di quanto lo sia quello della campana per la liturgia e questa, seppure eccezionalmente, può trovare nel luogo di lavoro uno spazio non meno indegno dell’oratorio. Non a caso poi, con accenti non dissimili da quelli usati da Benedetto per rendere solleciti i monaci all’opus Dei, Bernardo richiama al tempo del lavoro: «Ecco giunta l’ora nella quale la povertà e la nostra regola ci spingono a recarci al lavoro manuale». Del resto l’annunzio profetico che nella liturgia si fa della creazione nuova riveste di luce santa tutte le cose del mondo che in Cristo possono comunque essere segno della novità del Regno e strumenti di un’eucaristia cosmica: il cellerario del monastero dovrà pertanto trattare «tutti gli oggetti e tutti i beni del monastero come i vasi sacri dell’altare» (RB 31,10)./12 La parola di Basilio era già a monte della tradizione monastica nel ribadire l’avversione per ogni disarmonia fra preghiera e lavoro: «Quando il sole chiaramente risplende, ci si mette all’opera, mentre la preghiera ci accompagna in ogni luogo, e gli inni, come il sale, condiscono il lavoro» (Lettera II,2,41-42). E se nella tradizione romana il lavoro manuale ed agricolo era il proprium degli schiavi, attraverso di esso invece i monaci, «poveri con Cristo povero» (Exordium parvum di Cîteaux) e fatti creature libere e nuove dal servizio all’unico Signore e dai misteri celebrati nella liturgia, si rendono pienamente fratelli di lui e di tutta l’umanità nella fatica quotidiana assumendo consapevolmente la responsabilità della creazione affidata da Dio alle mani dell’uomo nelle prospettive bibliche sopra evocate. Contro la patologica degenerazione di certo monachesimo ridotto a pura laus perennis come sarà in certe riforme di età carolingia, la riforma cisterciense recupererà la predilezione di Benedetto per il lavoro agricolo, attraverso cui la comunità monastica ritrova e rinnova, coltivandola di stagione in stagione, l’antica terra promessa dal Signore a Israele e più ancora recupera nella testimonianza di vita la memoria evangelica ed apostolica: «se la condizione ambientale o la povertà del monastero esigono che i fratelli provvedano da sé direttamente al raccolto delle messi, non si rattristino per questo, perché proprio allora sono veri monaci, quando vivono del lavoro delle loro mani, così come fecero i nostri padri e gli apostoli» (RB 48,7-8)./13
Andrà infine collocata nello stesso primato
dell’amore per Cristo la non indolore scelta «di farsi eunuchi
per il regno dei cieli» (Mt 19,12) secondo un’esplicita parola
del Signore in cui è evidente la prospettiva escatologica che
deve caratterizzare il celibato: annunzio radicale e tuttavia
amoroso che, nonostante gli scherni di chi ci chiede «dov’è la promessa della sua
venuta» (2Pt 3,4), osa affermare che «il tempo ormai si è fatto
breve» e che «passa
la scena di questo mondo» (1Cor 7,29-31). La ferita
inferta su quel corpo di cui il monaco, conformato alla kenosi
amorosa del suo Signore, mai potrà sentirsi padrone (RB
33,4;58,25), non dovrà pertanto diventare sigillo di eroica
eccellenza ascetica, ma ancora una volta segno di un’eccedenza
di amore riconoscente per il Signore Gesù che donandoci il suo
Santo Spirito come vincolo di carità con la sua Sposa ci rende
capaci -Lui solo- di testimoniare il suo stesso amore che,
inaugurato il Regno, si dilata su tutta la creazione./14 Nessun arcigno
disprezzo dunque per i beni creati, nessuna moralistica
disistima per la corporeità, nessuna ingiustificabile
commistione con le derive gnostiche antiche e nuove, nessuna
minacciosa sottolineatura della provvisorietà del tutto
trascurato l’annunzio gioioso del mistero pasquale, ma
proclamazione del Regno e invocazione del ritorno escatologico
del Signore come definitivo rinnovamento di tutta la creazione
che il celibe dimostra di amare veramente nella misura in cui
testimonia allo stesso tempo, con la peculiare libertà
derivata dalla sua scelta, l’amore di Cristo stesso per tutti
gli uomini e le donne. A riguardo chi vuol farsi autentico
discepolo di Gesù, al di là dell’appartenenza a qualsiasi
specifica forma vitae ecclesiale, può forse
ragionevolmente trascurare l’incessante appello all’amore che
si ricava dal racconto dell’incontro di Gesù con la peccatrice
nella casa di Simone (Lc 7, 36-35)? O forse restare
insensibile alla stessa testimonianza dell’Apostolo che si è
«fatto tutto a tutti,
per salvare ad ogni costo qualcuno» (1Cor 9.22)? Un
grande maestro di vita monastica dei nostri tempi, Dom.
Benedetto Calati, ci ha fatto notare come nella migliore
tradizione monastica mai sia mancata la mirabile consuetudine
di una vera e costante amicizia che legava alle persone più
disparate il cuore di un moltitudine di monaci abitati da una
fortissima simpatia per Cristo: è solo in questa luce che ci
possiamo riappropriare più ragionevolmente del noto effato di
Evagrio Pontico, secondo cui «il monaco è colui che, separato
da tutti, è unito a tutti». Nel vincolo di amore e di libertà
del celibato, nel silenzio della quiete interiore, nella
verità dell’umile conoscenza di sé, nel digiuno e nella veglia
di chi attende lo Sposo gemendo di desiderio amoroso (Mt
8,14-15;24,42), il monaco, sostenuto dal Santo Spirito, vuole
intraprendere un progressivo cammino di cristificazione per
trasformare, con la compunzione del cuore, la sua interiorità
in luogo palpitante di riconciliazione con Dio, con se stesso
e con il prossimo. Memore che la carne è stata assunta dal
Verbo, egli potrà così testimoniare che il suo corpo non è
mortificante prigione ma giardino di libertà e di comunione da
irrigare costantemente con lo Spirito Santo per trasformare
pian piano il bramoso e infinito attaccamento a ciò che finito
in desiderio paziente e amoroso che già sa scorgere nel
frammento i segni dell’infinito nascosto e tuttavia promesso.
Si aggiunga che Benedetto non prevede alcun specifico voto di
castità ma di quest’ultima parla soltanto una volta e proprio
nel quarto capitolo dedicato agli strumenti delle buone opere
dove ai numeri 64 e 65 si legge: «Amare la castità. Non odiare
nessuno»: la correlazione è illuminante se si pensa che il
primo significato del termine castus in latino è, come
fa notare André Louf, “non
egoista”, “che
non sfrutta l’altro”. Si ama davvero e non si odia
davvero nella misura in cui il nostro cuore si sa depurare da
interessi e da attese egoistiche ogniqualvolta gli occhi si
aprono sull’altro di fronte a me, oltre ogni elementare e
istintiva brama di possesso o moto di ripulsa. Con la stessa
gratuità e assolutezza (ab-solutus) il monaco, perché
neppure da questo rischio siamo esenti, dovrebbe stare vicino
al suo Signore Gesù «senza distrazioni» (1Cor 7,35), senza
chiedere e aspettarsi nulla, nell’apparente, assoluta
privazione della potatura che dopo però sa restituire
vigore e forza ai rami per farli fruttificare. A questa stessa
gratuità di amore per il Signore Gesù che sa portare lo
sguardo sino all’orizzonte dei tempi ultimi sembrava voler
alludere Giovanni Paolo II scrivendo ai monaci certosini che
egli immaginava quasi sepolti nel cuore del Signore Gesù
mentre con immensa pazienza ricamano, attendendone il ritorno,
il velo mirabile che indosserà la sua Sposa alle nozze
escatologiche. Forse è proprio nel paradossale tentativo di
corrispondere all’incomprensibile gratuità dell’amore di Dio
per le sue creature che andrà individuato quel tratto
caratterizzante della vita monastica che nell’eloquenza del
silenzio, nella marginalità del deserto, nel travaglio austero
di un’inesausta conversatio e pure nell’apparente
inutilità di un’incessante dossologia di gesti e di parole
vuole trovare l’ultimo e irrinunciabile senso della sua
testimonianza. Non che le comunità monastiche possano e
debbano vagheggiare o esigere pretestuose esenzioni dal
tessuto vitale delle chiese locali e peggio ancora sentirsi in
ogni modo sollevati dalle responsabilità apostoliche che
comunque caratterizzano tutte le membra ecclesiali secondo
l’esplicito dettato conciliare,/15 ma certamente deve essere chiara e forte la
coscienza della necessità di una testimonianza altra
che il monastero deve saper narrare con la sua eccentricità
rispetto ai varî baricentri ecclesiali e politici. Nessuna
insapore omogeneizzazione, nessuna aspecifica ministerialità
ma percezione chiara di essere cuore nascosto della chiesa e
allo stesso tempo picchetto periferico che drizza la tenda
verso il cielo radicandola bene nel terreno. Dal monastero
-orto fecondo dove le parole dovrebbero essere rare perché «la Trinità è amica del
silenzio»/16 (e il silenzio è l’alfabeto proprio
dell’amore) e altresì officina simbolica protetta da
una clausura che è siepe di custodia e non muro invalicabile (RB
4,78)- si vorrebbe umilmente esortare ogni uomo e ogni donna a
vigilare contro l’azione disgregante di ogni diabolica
indifferenza o avversione alla memoria e alla speranza per
ricordarci finalmente che, al di là di tutte le
autoreferenziali sicurezze delle vecchie e nuove ideologie, «fuori della porta della
città» il nostro Signore ha patito ed è bene pertanto
intraprendere l’esodo «verso
di lui fuori dell’accampamento portando il suo obbrobrio
perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in
cerca di quella futura» (Eb 13,12-14). In tempi di
rimozione di tutto ciò che è autenticamente umano, e dunque
anche della stessa morte, il monaco, che è nello stesso tempo
per apparente paradosso creatura quaresimale e pasquale/17 (RB
49,1.7) e che ha «ha ogni giorno davanti agli
occhi il pensiero della morte» e al contempo «desidera la vita eterna con tutto
l’ardore spirituale» (RB 4,46-47), può farsi
testimone di una profezia nuova che pure geme dalla carne
ferita e bruciata di ogni credente. Nascosti con Cristo in
Dio, in desiderosa attesa di essere manifestati con lui nella
gloria (Col. 3,3-4), i monaci, in questi tempi duri di necrosi
della speranza e di sterile frammentazione dei desideri, è
bene che restino uomini e donne di frontiera. Solo
apparentemente sepolti nel silenzio delle loro «diocesi notturne»
(Thomas Merton), allenati a scrutare nella buio le sante
Scritture e a congedare con l’Alleluia (RB 9,9) le
ultime ombre che fan da sipario alla luce, perseverino come
sentinelle del mondo ad annunziare l’alba quotidiana come
prolessi di una storia tutta nuova. Nell’umile consapevolezza
dell’immensa fragilità del tutto, anche delle nostre venerande
e secolari istituzioni ecclesiali,/18 dopo duemila
anni di cristianesimo è ancora tutta da gridare la speranzosa
profezia che Bernardo di Clairvaux esigeva dai suoi monaci e
che dopo quasi mille anni deve continuare a incalzare anche
noi: «Fratelli miei,
quello al quale voi siete votati con la vostra vita
monastica, è il modo eccellentissimo di profetare. In che
cosa voi monaci dovete essere profeti? Non vedere ciò che è
visibile, ma tenere lo sguardo fisso sull’invisibile,
tendere verso ciò che sta davanti a voi, vivere di sola
fede, cercare le cose dell’alto. Un tempo i profeti hanno
meritato questo nome perché guardavano al loro futuro, a
Cristo, ma il vostro futuro è il Regno, e il Signore nella
gloria che viene» (Sermo de diversis 37,6).
Abbate Bernardo Francesco M. Gianni, OSB Oliv.
Abbazia di San Miniato al Monte,
Firenze
Notes
* Ho terminato la scrittura di queste pagine il 16 luglio 2003, giorno in cui la chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria del Carmelo. Con grato stupore per questa suggestiva coincidenza liturgica, che peraltro sento assolutamente non casuale, vorrei con sentimenti di viva amicizia dedicare questa riflessione a tutti i fratelli carmelitani scalzi della Provincia Toscana e attraverso di loro anche ai fratelli e alle sorelle della fraternità laicale carmelitana di Pisa. Memore che la mia vita ecclesiale è nata nel loro convento di Prato, non posso che ringraziarli benedicendo il Signore per la trasparente testimonianza di fede lì ricevuta in quegli anni decisivi di iniziazione alla vita cristiana.
1 J.
Daniélou, La teologia del giudeo–cristianesimo,
Bologna 1974, 215.
2 Un
magnifico passaggio della Gaudium et spes è pure a
monte di queste osservazioni: «l’attesa di una terra nuova non
deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine
nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel
corpo dell’umanità nuova che già riesce ad offrire una certa
prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si
debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo
sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui
può contribuire a meglio ordinare l’umana società, tale
progresso è di grande importanza per il regno di Dio» (39).
3 P.
Ricoeur, «Tâches de l’éducateur politique», in Esprit
33 (1965) 2, 92 citato in N. Valentini, «Un lembo della
corporeità raggiante», in Una spiritualità per il tempo
presente, a cura di N. Valentini, Bologna 2002 (Quaderni
di Camaldoli 22), p. 16.
4 «Sed
Benedictus, plus appetens mala mundi perpeti quam laudes, pro
Deo laboribus fatigari quam vitae huius favoribus extolli
deserti loci secessum petiit» (Gregorio Magno, Liber
Dialogorum II,1,3).
5 Benedetto
conclude la sua Regola al capitolo 73° dando una
modestissima valutazione del suo testo legislativo e
spirituale sottolineando più volte che si tratta di un minimo
ed elementare aiuto redatto per coloro che intendono muovere
«i primi passi sulla via della conversione» (RB 73, 1),
«principianti» sulla via di conversione. La Regola vorrebbe
essere come si direbbe oggi, un testo aperto:
Benedetto rimanda senza indugio il monaco che «vuole
affrettarsi verso la perfezione della vita monastica» (RB
73,2) agli insegnamenti dei santi Padri e più in generale alla
Sacra Scrittura, che già Cassiano riteneva punto di
riferimento, orientamento, norma e criterio di vita del
monaco: «Tenendo fisso lo sguardo alla meta, dobbiamo prendere
da essa la direzione e orientare la nostra corsa su questa
linea sicura. Se il nostro pensiero se ne allontana anche solo
di poco, dovremo rivolgere nuovamente là il nostro sguardo e
correggere le deviazioni» (Conlationes 1,4). E a questo
proposito Benedetto, nell’epilogo ora ricordato della sua
Regola, così s’interroga, non senza enfasi retorica: «Infatti,
quale pagina o quale parola rivelata, sia dell’Antico che del
Nuovo Testamento, non costituisce una norma rettissima per la
vita dell’uomo?» (RB 73,3).
6 A
proposito è tramandato un significativo detto attribuito al
padre Iperechio: «La gloria del monaco è l’obbedienza. Chi la
possiede è ascoltato da Dio, e con franchezza starà di fronte
al crocifisso, perché il Signore crocifisso si fece ubbidiente
fino alla morte». L’obbedienza significa così, come fa notare
l’abate Georg Holzherr nel suo magnifico commento alla Regola
di Benedetto, «fusione della propria volontà con quella di
Cristo e di Dio: ‘Sia fatta la tua volontà!’».
7 Ogni
monaco ha a cuore i consolanti versetti di Eb 5,8-9: «Pur
essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalla cose che patì e,
reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti
coloro che gli obbediscono».
8 Questo e
altri intenti si leggono nel «Foglio di presentazione del
monastero agli ospiti» pubblicato in Più forti dell’odio.
Gli scritti dei monaci trappisti uccisi in Algeria, a
cura della Comunità di Bose, Casale Monferrato 1997, pp.
29-30.
9 Per la
visione olistica della preghiera che ha Benedetto, cfr. RB
19,7: «e quando cantiamo i salmi cerchiamo di mettere in
sintonia il nostro cuore con la nostra voce».
10 Cfr. 1Ts
5,17; Lc 18,1 e RB 4,55-58; 16,1-3 e soprattutto
7,65-66 dove, illustrando il dodicesimo e ultimo gradino
dell’umiltà, Benedetto sembra proprio alludere a qualcosa di
molto simile alla preghiera del cuore: «E così va ripetendo
senza posa nel suo cuore le parole del pubblicano del Vangelo
che, con gli occhi abbassati, diceva: ‘Signore non sono degno,
io peccatore, di alzare gli occhi al cielo; e con il profeta
dice pure: ‘Mi sono curvato e umiliato fino all’estremo’».
11 E’
importante notare come nel racconto di Gregorio l’uomo di Dio
Benedetto, il monaco perseverante nello scrutare la volontà di
Dio nella sua Parola letta e celebrata, si renda capace, con
la sua parola profetica, di giudicare e discernere circa
l’agire storico del re goto Totila. Scoperto un
tentativo di inganno a suo danno, Benedetto,
significativamente qualificato da Gregorio come «servo del
nostro Signore Gesù Cristo», in un incontro con Totila ha per
questi una parola di giudizio, di rimprovero e di profezia che
non manca di incidere sulla condotta del sovrano che infatti
«da quel giorno fu meno crudele» (Liber dialogorum, II,
14-15).
12 Cfr. a
proposito i magnifici accenti di una passo della già citata
lettera apostolica Orientale lumen: «E anche la realtà
cosmica è convocata al rendimento di grazie, perché tutto il
cosmo è chiamato alla ricapitolazione nel Cristo Signore. Si
esprime in questa concezione un equilibrato e mirabile
insegnamento sulla dignità, il rispetto e la finalità della
creazione e del corpo umano in particolare. Esso, rigettato
parimenti ogni dualismo e ogni culto del piacere fine a se
stesso, diventa luogo reso luminoso dalla grazia e quindi
pienamente umano. A chi cerca un rapporto di autentico
significato con se stesso e con il cosmo così spesso ancora
sfigurato dall’egoismo e dall’ingordigia, la liturgia rivela
la via verso l’equilibrio dell’uomo nuovo e invita al rispetto
per la potenzialità eucaristica del mondo creato: esso è
destinato ad essere assunto nell’eucaristia del Signore, nella
sua Pasqua presente nel sacrificio dell’altare» (11).
13
Benedetto non pensa al lavoro come esito della situazione
post-lapsaria (cfr. Gn 3,23), ma sembra consapevole che fin
dalla creazione fosse inscritta da Dio nell’uomo la vocazione
al lavoro (cfr. Gn 2,15): non a caso il lavoro, «“sacrificio”
col quale l’uomo esercita il suo sacerdozio regale» (G.
Holzherr), è sempre visto sotto una luce di gioia e di fedeltà
alla testimonianza apostolica e alla storia presente. Oltre a
RB 48,7 sopra citato, ci testimonia questo orizzonte
l’episodio narrato da San Gregorio Magno in cui Benedetto
accomoda miracolosamente la falce rotta ad un monaco goto dal
quale si congeda con queste significative parole: «Ecce,
labora, et noli contristari» (Liber dialogorum II,6,2).
Ben istruttiva infine la conclusione del capitolo dedicato
agli artigiani del monastero che ci fa capire come anche nelle
relazioni commerciali i monaci abbiano l’occasione di
predicare la gloria di Dio: «Nel fare i prezzi, mai ci si
lasci prendere dal gran male dell’avarizia, ma anzi si venda
ad un prezzo più moderato di quello che possono fare i
secolari, perché in tutto venga glorificato Dio (1Pt 4,11)» (RB
57,7-9).
14 Cfr. a
proposito un intenso passaggio della Gaudium et spes:
«tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità,
dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del
Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di
nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e
trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il
regno eterno e universale (…). Qui sulla terra il Regno è già
presente, in mistero; ma con la venuta del Signore, giungerà a
perfezione». (39)
15 Il
decreto conciliare sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae
Caritatis (1965) al numero 5 prescrive molto chiaramente
a tutti i religiosi appartenenti a qualsiasi ordine una
ministerialità apostolica, adeguatamente ritmata e sostenuta
dall’esperienza “contemplativa”, anche secondo una ben
attestata tradizione patristica: «è necessario che i membri di
qualsiasi istituto, cercando sopra ogni cosa e unicamente Dio,
uniscano la contemplazione, con cui aderiscono a Dio con la
mente e col cuore, e l’ardore apostolico, con cui si sforzano
di collaborare all’opera delle redenzione e dilatare il regno
di Dio». Più specificamente ancora Perfectae Caritatis
a proposito del rinnovamento e dell’aggiornamento della vita
monastica aggiunge al numero 9: «Mantenendo l’indole
caratteristica del proprio istituto, i monaci rinnovino le
antiche benefiche tradizioni e le adattino agli odierni
bisogni delle anime, in modo che i monasteri siano come vivai
di edificazione del popolo cristiano». Il Magistero è poi
successivamente tornato con grandissima autorevolezza a
ribadire le linee essenziali del carisma e del ministero
monastico in relazione al bene dell’intero popolo di Dio. Cfr.
infatti a proposito Vita Consecrata: «Anche i monaci
di oggi si sforzano di conciliare armonicamente la vita
interiore e il lavoro nell’impegno evangelico della
conversione dei costumi, dell’obbedienza, della stabilità, e
nell’assidua dedizione alla meditazione della Parola (lectio
divina), alla celebrazione della liturgia, alla
preghiera. I monaci sono stati e sono tuttora, nel cuore della
Chiesa e del mondo, un eloquente segno di comunione,
un’accogliente dimora per colore che cercano Dio e le cose
dello spirito, scuole di fede e veri laboratori di studio, di
dialogo e di cultura per l’edificazione della vita ecclesiale
e della stessa città terrena, in un’attesa di quella celeste»
(6). Fra i detti dei Padri del Deserto ne è sopravvissuto uno,
attribuito ad abba Pambo, che ci pare assai efficace per
illuminarci circa la più genuina e tradizionale specificità
apostolica del monachesimo: «Abba Pambo interrogato circa
l’ospitalità così rispose: “Tutti gli ospiti che vengono da
noi, salvo i curiosi, prima di andarsene chiedono: ‘Abba,
dimmi una parola!’. Se la ricevono, ritorneranno, altrimenti
la cercheranno da altre parti… Ecco dunque il nostro grande
compito nell’ospitalità: donare una parola! A volte sarà
direttamente la Parola di Dio, altre volte semplice traccia
che alla Parola conduce, altre ancora sarà eco della Parola di
Dio, oppure silenzio che la Parola adora e ascolta.
Nell’incontro con gli ospiti l’importante è consegnare loro
ciò che noi contempliamo in verità nell’umile e nobile
servizio del monaco”».
16 La
suggestiva intuizione è di Adamo di Perseigne, monaco
cisterciense del secolo XII.
17 «La vita
del monaco dovrebbe essere tutta improntata all’austerità
quaresimale… e così attenda la santa Pasqua nella gioia del
più intenso desiderio spirituale»: RB 49,1.7.
18 Molto
giustamente Dom. Benedetto Calati ha notato che «il primato
dell’Amore a Cristo presenta la comunità monastica nella
provvisorietà di ogni istituzione. La vita di S. Benedetto,
dataci da S. Gregorio Magno, papa e monaco, ha due narrazioni:
la profezia della fine di Roma e quella della distruzione di
Monte Cassino. Sono due fatti che segnano profondamente
l’epoca di Gregorio Magno e di Benedetto. La fine dell’impero,
la fine della polis del mondo, inserita nella vita di
S. Benedetto, sta a significare che il monaco, per la sua
dedizione a Cristo, si presenta come l’uomo in cammino, con lo
sguardo aperto al futuro, segno di speranza, segno di un mondo
nuovo e dei cieli nuovi in cui abita la giustizia. Benedetto
non fugge dal mondo, ma con la preghiera e il lavoro getta le
basi della nuova polis, la comunità monastica, che è
segno umile e povero del Regno per l’amore che inabita. Ma se
viene meno la patria, Roma, il monaco potrà aggrapparsi alla
propria istituzione. Anche questa però è nel provvisorio:
Cassino, il cenobio costruito con tanta fatica da S.
Benedetto, sarà distrutto dai Longobardi. Il sant’uomo ottiene
che i monaci siano salvati. Come S. Paolo nel naufragio di
Malta, osserva Gregorio, perdette l’imbarcazione, ma salvò le
persone (At 27). Il monastero, l’istituzione monastica, cioè,
è sì una barca, ma provvisoria, precaria. Tale è la lettura
profetica che si può fare dei due avvenimenti storici
collocati nella vita di S. Benedetto. Gregorio Magno autorizza
questa lettura profetica» (B. Calati, Monachesimo
benedettino, in Id., Sapienza Monastica. Saggi di
storia, spiritualità e problemi monastici, a cura di A.
Cislaghi e G. Remondi, Roma 1994 (Studia Anselmiana
117), 430-431. Le due profezie a cui fa qui riferimento il
Padre Calati, relative rispettivamente alla distruzione di
Roma e a quella di Monte Cassino, si leggono nel Liber
dialogorum II,15,3 e II,17,1-2.
![]()
| If you have used and enjoyed this page please
consider donating to the research and restoration of
Florence's formerly abandoned English Cemetery by the Roma and its Library through our Aureo Anello Associazione's account with PayPal: Thank you! |
![]()
JULIAN OF NORWICH, HER SHOWING OF LOVE
AND ITS CONTEXTS ©1997-2022 JULIA BOLTON HOLLOWAY
|| JULIAN OF NORWICH || SHOWING OF
LOVE || HER TEXTS ||
HER SELF || ABOUT HER TEXTS || BEFORE JULIAN || HER CONTEMPORARIES || AFTER JULIAN || JULIAN IN OUR TIME || ST BIRGITTA OF SWEDEN
|| BIBLE AND WOMEN || EQUALLY IN GOD'S IMAGE || MIRROR OF SAINTS || BENEDICTINISM|| THE CLOISTER || ITS SCRIPTORIUM || AMHERST MANUSCRIPT || PRAYER || CATALOGUE AND PORTFOLIO (HANDCRAFTS, BOOKS
) || BOOK REVIEWS || BIBLIOGRAPHY ||